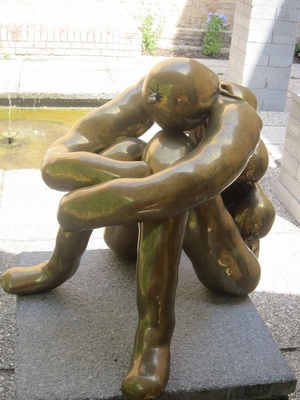
Quando e dove ebbe origine quei contenuti che in seguito saranno indicati come "metafisica"?
Noi possiamo lavorare di fantasia pensando che dall'oriente, dalla Sumeria e dall'Egitto possono essere arrivate delle persone che nei popoli mediterranei hanno introdotto la visione degli Dèi e di una realtà trascendente che descrivevano.
Si tratta di condizioni che possono essere, ma non è detto che siano.
All'inizio del primo libro, Diogene Laerzio afferma, riferendosi ad Aristotele nel "libro magico" e Sozione nel libro ventesimo della "Sucessione dei filosofi", che gli inventori della filosofia furono i Magi presso i persiani.
Dalle ultime ricerche alcuni studiosi collocano il personaggio Zarathustra tra il XVIII e il XV secolo a.c. anche se altri studiosi lo collocano fra l'XI e il VII secolo a.c.
E' difficile considerare questo tipo di influenza alla base della metafisica come è giunta fino a noi.
A me interessano le basi storiche, abbastanza certe, sull'origine della metafisica e, per quanto ci può interessare, alla base della metafisica ci fu il culto dionisiaco, i culti orfici, che videro Museo, Omero ed Esiodo raccontare degli Dèi.
Chi ci testimonia questo?
I filosofi e la guerra che i filosofi ingaggiarono contro il mito.
Per esempio, Senofane di Colofone:
Scrive Laura Gemelli Marciano parlando di Senofane di Colofone:
Egli attacca sia la rappresentazione degli dèi, sia le presunte concezioni astronomiche, cosmogoniche e cosmologiche dei poeti epici che si sono addentrati in queste zone del passato e del presente inaccessibili alla conoscenza umana. I temi annunciati nell'invocazione alle Muse della Teogonia esiodea sono, infatti, la nascita degli dèi, della terra e del cielo (cfr. nota a 37 B, 4) e anche Omero parla della generazione degli dèi da Oceano e Tethys e di altri temi cosmologici. Il frammento di Senofane si situa dunque sulla linea della critica ai poeti epici che, pur coscienti dell'incapacità degli uomini di conoscere tutti questi ambiti, si appellavano all'ispirazione delle Muse, testimoni oculari degli eventi da loro narrati (cfr.nota a 37 B, 4).
Laura Gemelli Marciano, Sentieri di sapienza attraverso la Ionia e oltre da Talete ad Eraclito, Editore Valla, 2023, pag. 313
E ancora:
6 A. Diogene Laerzio, IX 18 (DK 21 A 1)
[...] [Senofane] viene lodato da Timone [fr. 60, 1 Di Marco];
dice dunque:
Senofane, quasi immune da vanità, fustigatore dell'inganno omerico. [...] Scrisse sia in versi epici, sia elegie e giambi contro Esiodo e Omero, biasimando quanto essi hanno detto sugli dèi.
6 B. Sesto Empirico, Contro i Matematici IX 193 (DK 21 B 11)
Infatti essa [scil. la mitologia dei teologi e dei poeti] è piena di ogni genere di empietà. Perciò anche Senofane, confutando Omero ed Esiodo, afferma:
Omero ed Esiodo hanno attribuito agli dèi tutto
quanto presso gli uomini è vergogna e biasimo:
rubare, commettere adulterio e ingannarsi a vicenda
6 C. Sesto Empirico, Contro i Matematici I 289 (DK 21 B 12)
Omero ed Esiodo, poi, secondo Senofane di Colofone, hanno cantato empie azioni degli dèi, quante più ne potevano: rubare, commettere adulterio e ingannarsi a vicenda.
Laura Gemelli Marciano, Sentieri di sapienza attraverso la Ionia e oltre da Talete ad Eraclito, Editore Valla, 2023, pag. 323/325
Senòfane di Colofone, (570 a.c. – 475 a.c.) fu un contemporaneo di Pitagora e, si dice, uno dei maestri di Parmenide.
Lo stesso Pitagora di Samo, (tra il 580 a.c. e il 570 a.c. – Metaponto, 495 a.c. circa) aveva in odio i poeti.
Ieronimo dice che Pitagora sarebbe disceso nell'Ade e avrebbe visto l'anima di Esiodo legata a una colonna di bronzo e intenta a strillare e quella di Omero appesa ad un albero e circondata da serpenti: questo come punizione per ciò che entrambi avevano detto riguardo agli Dèi. Avrebbe anche visto puniti coloro che non volevano unirsi alle proprie mogli. E proprio per questo sarebbe stato onorato dai Crotoniati.
Laura Gemelli Marciano, Sentieri di sapienza attraverso la Ionia e oltre da Talete ad Eraclito, Editore Valla, 2023, pag. 185
E questo per non parlare dello stesso Platone:
Scrive Laura Gemelli Marciano sulle idee che Platone aveva di Museo e degli Orfici:
Non a caso l'immagine che egli [Platone] offre dei seguaci di Orfeo e Museo è quella di vagabondi che bussano alle porte dei ricchi offrendo iniziazioni consistenti solo in banchetti e simposi senza alcun altro carico o responsabilità. La dicotomia, diffusa fra gli studiosi moderni, fra orfici, che si limiterebbero al rituale senza implicazioni etiche, e pitagorici, che invece impostano il percorso su un sistema di vita regolato da precetti etico-religiosi, è in parte una diretta conseguenza di questa presentazione platonica che ha volutamente sottaciuto le implicazioni morali del percorso iniziatico.
Laura Gemelli Marciano, Da Velia ad Agrigento, Ed. Valla, 2024, pag. 129
Nella “Repubblica”, Platone fa un ampio discorso contro i poeti e la poesia. Sia nel Terzo libro che nel Nono Libro de La Repubblica.
Scrive Platone:
"Bisogna dunque, a quanto sembra, che anche a proposito di questi Miti, teniamo sotto controllo quelli che vogliono raccontarli, invitandoli a non squalificare, così alla leggera, i fatti che avvengono nell'Ade, ma anzi a rivalutarli; tanto più che le loro narrazioni non hanno alcun fondamento di verità e neppure sono utili a chi dovrò avere spirito combattivo."
Platone, La Repubblica, in "Platone, tutti gli scritti", Editore Bompiani, 2014, p. 1132
Ogni filosofo che si oppone al mito in nome di una qualche forma di dittatura assolutista. espone le sue ragioni per negare il mito e per combattere i soggetti che "dominano" la sua realtà filosofica e religiosa. Ma tutti i filosofi che combattono i Miti hanno uno scopo fondamentale: la dittatura e la riduzione dell'uomo in uno schiavo sottomesso a qualche eletto. Il loro concetto di leggi non è quello della legge che libera l'uomo da una qualche costrizione, ma quello di leggi che obbligano l’uomo rendendolo schiavo a virtù e doveri quale prodotto della necessità del filosofo di dominare l’uomo.
Lo stesso concetto di anima, imposto da Pitagora e Platone, è l'opposto del concetto di Daimon, le emozioni dell'uomo e della vita. Secondo Platone, l'uomo non ha diritto alle emozioni, non ha diritto a piangere o a disperarsi perché l'uomo virtuoso, il macio, l'ideale macista proprio dell'omosessuale che odia le donne perché gli sono concorrenti, non piange né si dispera.
Possiamo considerare che la metafisica entra nella cultura umana con Orfeo, Museo, Omero ed Esiodo. Entra come modelli simbolici, come arte mimetica, che presentano principi, situazioni e modelli che fungono da guida all'uomo nelle condizioni della sua esistenza.
La metafisica non separa l'anima dalla donna e dall'uomo. Non ha il concetto di anima, ma i corpi, raccontati dal Mito, sono allo stesso tempo corpi fisici, per la rappresentazione estetica, e corpi di energia, per la rappresentazione reale del modello comunicato.
A differenza dei filosofi, la metafisica del Mito non discrimina le donne rispetto all'uomo. Nella grande cosmologia della Teogonia di Esiodo le figure divine femminili non sono inferiori alle figure divine maschili. C'è una differenza di ruolo, non una differenza gerarchica.
Per iniziare a parlare di metafisica diventa necessario riprendere alcuni aspetti del Mito in relazione sia agli Orfici che al Dionisismo.
Ho già dato l'interpretazione alla Teogonia di Esiodo e, in molte pagine, anche delle "opere e i giorni" di Esiodo. Ho dato varie interpretazioni all'orfismo, al Papiro di Derveni, alla Laminette Orfiche e ai misteri Eleusini con l'Inno Omerico a Demetra. Ho lavorato ampiamente sui, sia pur tardi, Inni Orfici e ho analizzato, sia pur come impressione superficiale, i frammenti degli Oracoli Caldaici. Il tutto caricato in internet e disponibile alla ricerca.
Ma qui siamo davanti ad un percorso, sia pur disordinato, nella lotta fra la metafisica e l'assolutismo che pretende di trasformare l'uomo in uno schiavo sottomesso e, per farlo, nega all'uomo la sua divinità, la sua vita come esistenza divina e la divinità di un'oggettività che chiama l'uomo a riprendere il suo posto nella Natura sottraendosi alla sottomissione.
Gli Dèi dei metafisici sono la vita stessa. Gli Dèi sono sia i soggetti che l'ambiente in cui i soggetti si trasformano. Gli Dèi indicano una perenne trasformazione dell'ambiente perché gli Dèi sono in perenne trasformazione. I filosofi hanno paura della trasformazione: devono chiudere tutto l'esistente in una verità manifestata dal lor Dio padrone, l'Artefice, l'Uno, il Tutto, ecc. E questo allontanerà gli uomini dalla possibilità di analisi del loro presente e dal pensare quali azioni mettere in atto per divenire e trasformarsi.
I filosofi portano l'uomo all'impotenza, al ruolo di schiavo, di bestiame, un oggetto d'uso, di cui loro si ergono a padroni e gestori in nome di Dio, dell'Artefice, dell'Uno, del Tutto. Platone provvederà a trasformare gli Dèi, a fondamento della vita, in "demoni" da disprezzare e, disprezzando gli Dèi chiamandoli demoni, porterà l'uomo al fallimento della sua esistenza.
Questo è l'inizio della storia della metafisica che voglio raccontare. Non è l'inizio del mio cammino, ma il punto d'arrivo del mio cammino che, in questa storia, iniziò riflettendo su Karl Leonhard Reinhold (1758 - 1823) e l'affermazione sintetica delle sue idee fatta dal Bignami di filosofia che diceva:
1) la rappresentazione della Coscienza si riferisce sia al soggetto (rappresentante) che all'oggetto (rappresentato) ed è distinta da entrambi. Ciò che nella rappresentazione si riferisce al soggetto è la forma, ciò che si riferisce all'oggetto è la materia.
Bignami III filosofia per licei.
Da qui iniziò questo cammino oltre trent'anni or sono. Qui sono arrivato e da dove sono arrivato voglio iniziare questa storia di metafisica che vi racconto. Se oggi dovessi ricominciare dall'inizio rifletterei in maniera diversa su molte cose che ho scritto. Il mio è stato un cammino di conoscenza. Una conoscenza che non avevo quando iniziai ad affrontare le prime idee filosofiche. Avevo solo la necessità di presentare la mia percezione del mondo ad una filosofia che ne negava la realtà.
L'origine della filosofia
Da Dioniso a Gesù: i modelli letterari
Riflessione sull'orfismo e sul dionisismo
Riflettere sulla possessione e sull'invasamento
Nietzsche e Dioniso nel delirio bacchico la percezione razionale e la percezione dionisiaca 19
Riflessione su invasamento, possessione e delirio
Dioniso e le Baccanti di Euripide
Le baccanti e il sacrificio dello smembramento
Il Discorso Sacro dell'orfismo
Pitagora: ricerca di conoscenza o tecnica del dominio dell'uomo sull'uomo?
Parmenide e la filosofia metafisica nel Poema sulla Natura
Sito di Claudio Simeoni
Ultima formattazione:
Marghera, settembre 2025
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
Tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
Ultima modifica settembre 2025
Questo sito non usa cookie. Questo sito non traccia i visitatori. Questo sito non chiede dati personali. Questo sito non tratta denaro.